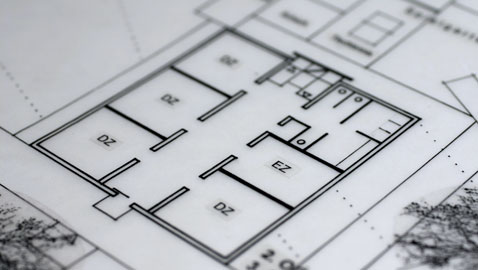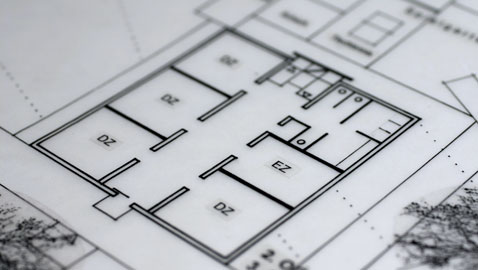Il diritto d’abitazione, traendo origine nell’usus domus del diritto romano, ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata di cui all’art. 1350 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 4562/1990).
Il codice civile prevede, all’art. 540, un’unica ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione precisando che al coniuge del defunto, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili
Sembra possibile che il diritto di abitazione possa costituire anche in presenza del diritto di usufrutto in quanto l’usufruttuario può concedere tale diritto a terzi in quanto avente una espansione di godimento più ristrettaci quella dell’usufrutto.
Il diritto di abitazione, è disciplinato dall’articolo 540, secondo comma, del Codice Civile e presuppone il godimento, riservato al solo coniuge superstite, “anche quando concorra (all’eredità, ndr) con altri chiamati”, dei diritti abitativi sulla casa adibita a residenza familiare e dei diritti di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nell’ex casa coniugale è, al pari dell’usufruttuario, l’unico soggetto passivo ai fini delle imposte Imu, a prescindere non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l’immobile, ma anche a prescindere dall’effettiva fruizione dello stesso diritto di abitazione.
Nell’ipotesi di usufrutto, non appare necessario che l’usufruttuario costituisca in favore di se stesso un diritto di abitazione in quanto l’usufrutto è un diritto reale di godimento che ha una maggiore estensione; potrebbero i comproprietari qualora le pertinenze indicate siano riferibili all’immobile in questione trasferire l’usufrutto delle suddette pertinenze.
Ricordiamo quanto a queste una regola base per l‘Imu sulle pertinenze: il numero massimo di pertinenze che si possono conteggiare per un’abitazione principale è pari a tre. Queste devono risultare necessariamente accatastate come C2, ovvero magazzini e locali di deposito come cantine e solai, C6, categoria che identifica stalle e scuderie o garage, oppure C7, valida per tettoie sia chiuse che aperte.
La regola ha portata nazionale perché sulla disciplina delle pertinenze i Comuni non hanno discrezionalità. Va chiarito però un limite fondamentale: le tre pertinenze dell’abitazione principale devono appartenere a categorie catastali diverse. Facciamo un esempio pratico: se una casa dispone di una cantina e di un solaio, entrambe C2, non è possibile, ai fini IMU e TASI, considerarle entrambe come pertinenze dell’abitazione principale. Altro elemento necessario è che l’immobile sia l’abitazione principale del coniuge superstite. Infatti, sensi del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, per abitazione principale si intende
“l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Lo stesso D.L. n. 201/2011, dispone altresì che
“nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.