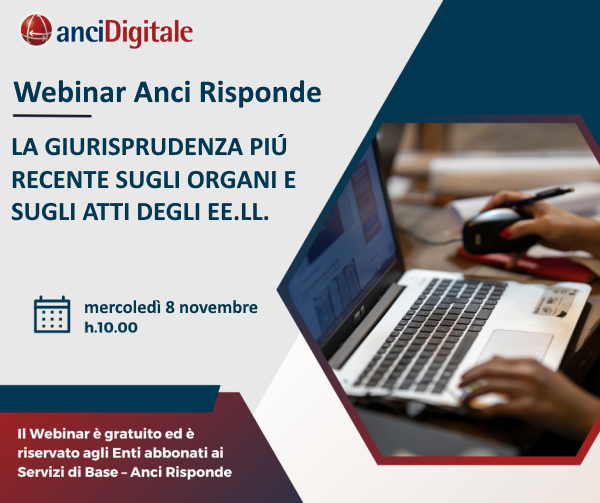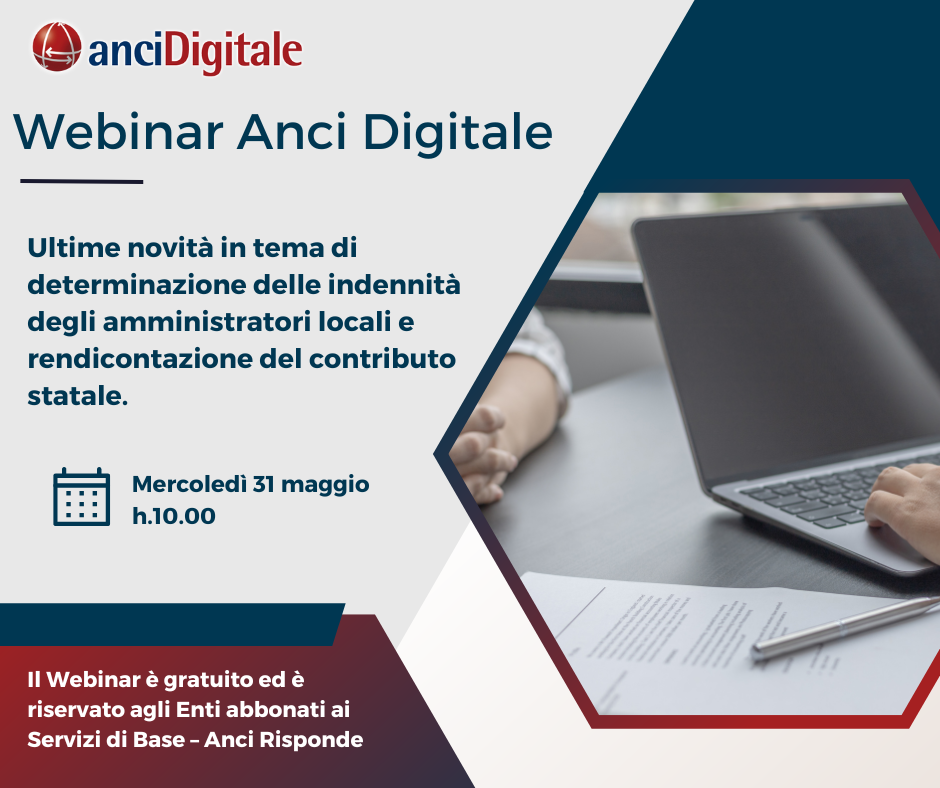Non tragga in inganno il titolo: qui non si tratta di argomenti politici, ma mitologici (per quanto oggi i due campi sembrano avere molti punti di contatto).
Il ritorno di Ulisse ad Itaca, il suo approdo sulla spiaggia del porto sacro a Phorkys, dove viene deposto ancora addormentato, dà modo ad Omero di tratteggiare con rapide pennellate un paesaggio (Odissea XIII, 102-112), dove spiccano due elementi enigmatici: in capo al porto una pianta di ulivo dalle ampie foglie (tanyphyllos elaie) e nelle sue vicinanze una strana caverna (antron).
La caverna presenta spiccate caratteristiche simboliche, che ne fanno uno psicocosmogramma, ossia una rappresentazione del cosmo in relazione al movimento e alle vicissitudini delle anime umane.
Investigato nel corso dei secoli il significato di questa caverna particolare (dalle due entrate, buia, dove le ninfe tessono su enormi telai di pietra stoffe purpuree preziosissime ed altre amenità del genere), sono molteplici le opere che ne hanno trattato. Una delle prime e più famose è L’antro delle ninfe del libanese Porfirio.
Neoplatonico, pitagorico, allievo di Plotino, profondo conoscitore dei misteri egizi, caldei ed ebraici, in questa operetta, esamina il significato simbolico delle 10 righe omeriche.
Rapito dalla sua lettura, mi lascio trasportare dalla sua ricerca di un senso nascosto (hyponoia).
La pianta di ulivo che Omero pone in capo al porto è un albero sempreverde (aeithales); esso possiede inoltre la caratteristica di volgere la parte bianca delle foglie verso l’alto in estate e verso il basso durante l’inverno. Ciò lo rende consonante al corso del sole. Ecco la ragione, spiega Porfirio, per la quale durante le preghiere e le suppliche si tendono ramoscelli di ulivo: ciò equivale all’augurio che le tenebre dei pericoli si mutino in candore.
Dedicato ad Atena, la corona fatta di suoi ramoscelli è posta sul capo agli atleti vincitori. L’intelligenza divina sempre fiorente che guida l’universo concede “i premi alla vittoria degli atleti della vita”.
Del passo omerico viene offerta la seguente esegesi simbolica: “Giunti a questa caverna, bisogna deporre ogni possesso esterno, denudarsi e assumere l’aspetto di un mendico dal corpo avvizzito, gettare ogni cosa superflua, staccarsi dalle sensazioni e allora deliberare con Atena, seduto con lei ai piedi dell’ulivo, su come eliminare tutte le passioni che traviano la propria anima.”
Vicino, molto vicino è il simbolismo che il Cristianesimo adotterà poi: l’atleta vincitore della vita diviene il martire raffigurato con la palma vittoriosa; l’ulivo segno di pace, è portato dallo Spirito Santo; la Domenica delle palme, vede noi Latini adoperare ramoscelli di ulivo per acclamare il Redentore nel suo ingresso trionfale a Gerusalemme, in perfetta continuità con l’augurio sopra riportato.
Segni di una realtà superiore, i miti e le favole così sono descritte da Porfirio, alla fine della sua opera: “pensando a quanto grandi furono la sapienza degli antichi (palaian sophian) e l’intelligenza di Omero (hOmerou phronesis) e la sua perfezione in ogni virtù (pases aretes akribeian) non si disconosca che egli ha nascosto l’immagine di realtà più divine (eikonas ton theioteron) sotto la finzione di una favola (en mythariou plasmati) …”.
L’accoglienza dunque tributata all’anima che torna alla sua dimora, vittoriosa come Ulisse, è nella figura di Atena, nata dalla testa di Zeus; nel suo atteggiamento, ad un tempo materno e cameratesco, di aiuto contro le passioni l’anima trova ristoro. All’ombra dell’Ulivo.