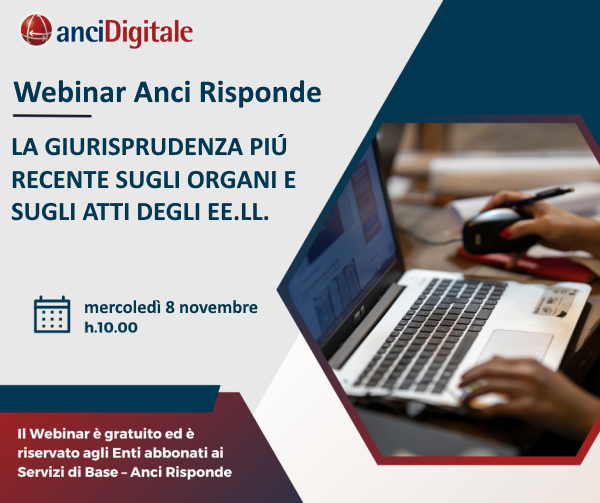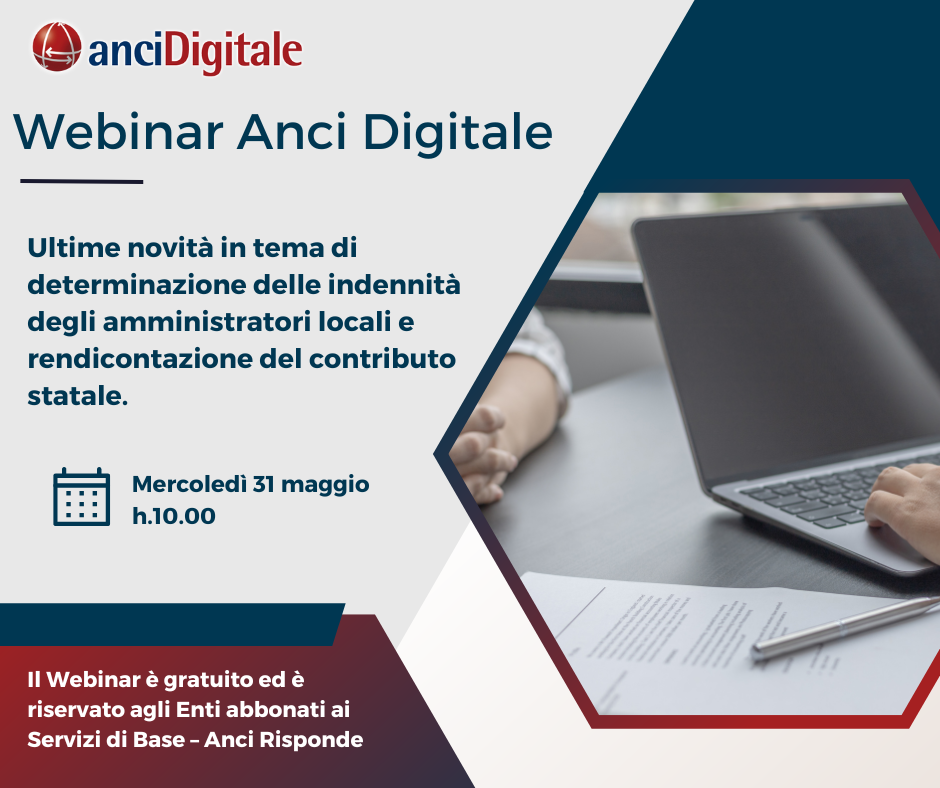Flavius Valerius Constantinus I, detto “il Grande”, fu a capo dell’Impero Romano dal 306 al 337 d.C. e si formò alla corte di Diocleziano, che stava già apportando le prime riforme amministrative all’immenso (ed ormai “traballante”) apparato statale dell’Urbe.
Valoroso guerriero e tribuno durante gli anni della sua gioventù, il suo nome ed il suo mandato sono indissolubilmente legati all’emancipazione del Cristianesimo e alla sua diffusione su larga scala territoriale. Grazie alle imprese militari, Costantino venne nominato imperatore per acclamazione nonostante le congiure ai vertici dell’Impero fossero all’ordine del giorno ed i poteri degli eletti non venissero riconosciuti “tout court” dai vari governanti regionali.
Solo nel 312, sconfitto Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, fu assurto dal Senatus alla carica di Augusto, e diede luogo ad una diarchia con Licinio non esente anche questa da regolamenti di conti intestini e feroci lotte di potere. Alcune ricostruzioni storiografiche secondo le quali egli fu il vero artefice della diffusione del Cristianesimo come nuova religione di Stato, benchè contraddittorie, mettono comunque in evidenza quanto i suoi interventi avessero funto da spinta propulsiva per alcuni cambiamenti che rappresentarono una svolta per tutto il mondo paleocristiano.
In realtà, Costantino non fu il primissimo imperatore a decretare ordinanze tese a legalizzare la religione monoteista : già alcuni anni prima infatti, Gallieno e Gallerio, in relazione alla crescente diffusione (anche ad Oriente) del nuovo culto, avevano emanato dei provvedimenti di tolleranza che di fatto permettevano parzialmente di praticare la confessione cristiana entro i confini dell’Impero. Tuttavia, tali provvedimenti non avevano lasciato particolari tracce circa l’aspetto urbanistico di Roma : un qualsiasi visitatore avrebbe notato i grandi palazzi governativi, i templi dedicati agli antichi dèi, le domus e così via. D’altra parte, con l’Editto di Milano del 313, Costantino e Licinio altro non fecero che ratificare ufficialmente l’autorizzazione per i cristiani ad esercitare il loro libero diritto di culto, ma in più ne estesero le prerogative.
Non è chiaro se ai tempi della consacrazione come imperatore Costantino si fosse già convertito, ma ciò che assunse enormi contenuti politici fu il suo progetto di cristianizzazione dell’Urbe, molto presumibilmente già insito da tempo nelle sue intenzioni. Quel provvedimento, infatti, è considerato dagli storici – anche in questo caso non abbastanza concordi – come l’evento che determinò il cambiamento epocale dell’antico rapporto tra Impero e Chiesa quali soggetti in precedenza reciprocamente ostili ma in seguito compatibili e sinonimo di arricchimento del sistema.
Benchè le siffatte persecuzioni e le deportazioni di fedeli cristiani continuassero a perpetrarsi anche durante e dopo l’Editto costantiniano, queste, dopo le nuove ordinanze, tesero a diminuire progressivamente. I sentimenti anticristiani legati al paganesimo, ancora forti e di cui il poderoso apparato burocratico dell’Impero era simbolo, andarono via via a “cozzare” sulla effettiva impossibilità di contenere il proselitismo della nuova religione anche al di fuori dei confini romani ed italici dell’Impero. Oltretutto, le riforme costantiniane impressero un indirizzo meno romanocentrico e più ellenistico alla politica imperiale, che acquisì una nuova fisionomia proprio sulla base della penetrazione del Cristianesimo in tutto il mondo tardo-antico. D’altra parte, nato a Mesia (l’attuale Serbia), l’impegno militare del neoimperatore si dipanò prevalentemente nelle aree mediorientali, greche e balcaniche, luoghi presso i quali passò la maggior parte della sua vita ed il suo excursus honorum.
Certo è che durante gli anni che seguirono all’insediamento costantiniano, a Roma ebbe luogo un fiorire di chiese e di monumenti dedicati alla religione cristiana di inestimabile ricchezza storico-architettonica e di enorme significato figurativo. “Il Grande” pose in essere una attività edilizia concentrata ad affermare entro i suoi domìni il trionfo del Cristo che lo aveva assistito durante le guerre e la scalata al potere. Nonostante nella macchina amministrativa imperiale (ancorchè nell’esercito e nella società civile) fossero ormai già presenti molti cristiani, egli accelerò la trasformazione della Chiesa in una importante istituzione politica, oltre che religiosa.
I vescovi iniziarono ad esercitare una carica simile a quella degli alti funzionari laici, ed al loro vertice venne stabilito che ci fosse una guida spirituale oltre che carismatica : il Vescovo d’Occidente (il termine “papa” cominciò ad essere usato più tardi). Ad ogni modo, il moltiplicarsi delle domus ecclesiae nelle periferie non implicava la costruzione di centri di culto cristiani nelle zone in cui sorgevano i grandi palazzi di proprietà del Senatus pagano, anche perché poco consigliabile, ma l’imperatore decise di invertire la tendenza. E lo fece in primo luogo rivedendo i canoni urbanistici del centro dell’Impero dando la sensazione di voler riformare lo standard ideale che prevedeva la presenza esclusiva in città dei palazzi politici.
Nei primi mesi del suo mandato, Costantino aveva già in mente il modo in cui “cristianizzare”, sotto l’aspetto puramente edilizio, Roma e le sue province. Intorno al 313, una volta abbattuti gli edifici per le allora guardie imperiali a cavallo, fece costruire al Laterano una grande cattedrale per il vescovo di Roma, ovvero quella che successivamente sarebbe divenuta l’attuale San Giovanni in Laterano, la quale conserva ancora le antiche mura e le prime fondamenta. La basilica, l’annesso Battistero e pochi passi dopo Santa Croce in Gerusalemme, edifici eretti nello stesso periodo, mostrarono la volontà di “rompere” gli schemi convenzionali fondati sulla imponenza dei palazzi imperiali e porre sullo stesso piano, per bellezza, maestosità, decorazione e colpo d’occhio, le costruzioni dedicate al Cristo Re. I tre luoghi di culto citati, che furono gli unici eretti entro le mura da Costantino, per caratteristiche e significato – vedi la basilica tondeggiante – rappresentarono un’innovazione assoluta.
Più varia invece fu la cristianizzazione delle campagne intorno Roma : tra il 313 ed il 337 sorsero una serie di costruzioni il cui punto in comune era rappresentato dalla basilica e dagli ambienti per i rituali.
Queste in origine avevano solamente funzioni estetiche, ma successivamente fu previsto e stabilito che contenessero al loro interno le catacombe per i martiri ed i fedeli e avessero dei locali adibiti per le celebrazioni funebri. Una delle diverse chiese costantiniane costruite fuori le mura e “sopravvissute” a quasi duemila anni di storia, anche se più volte ristrutturata, è quella di San Sebastiano sulla Via Appia, eretta probabilmente in onore dei 12 Apostoli. Un’altra basilica cimiteriale sorse in Via Tiburtina, riccamente decorata da Costantino, sui cui resti ed i terreni sorse l’attuale chiesa di San Lorenzo Fuori le Mura, e i cui antichi porticati conducevano addirittura sino all’interno della città mediante una delle sue aperture.
Un raro capolavoro di ingegneria architettonica è rappresentato dalla chiesa di Sant’Agnese, sita in Via Nomentana, eretta dalla figlia dell’imperatore Costanza presso le sue vecchie tenute di campagna, la quale conserva ancora le pareti esterne originarie. Il mausoleo che la principessa volle far costruire di fianco alla basilica è al suo interno ricco di capitelli e splendide decorazioni marmoree e musive solo in parte conservate, ma che fanno intuire il valore figurativo delle opere.
Anche San Pietro, il tempio della cristianità, venne fondato da Costantino alle pendici del colle Vaticano (allora in aperta campagna) negli anni compresi tra il 319 ed il 329. Per sontuosità e grandezza fu l’opera più grande, ma come importanza e significato l’imperatore attribuì a questo edificio un ruolo simile a quello di S. Giovanni. La grande chiesa divenne – come ordinato dallo stesso Costantino – la meta principale dei pellegrinaggi cristiani e fu decorata al suo interno da preziosi suppellettili in oro e argento come la grande cattedrale lateranense, alla quale per diverso tempo spettò ancora il ruolo di principale tempio del Cristianesimo.